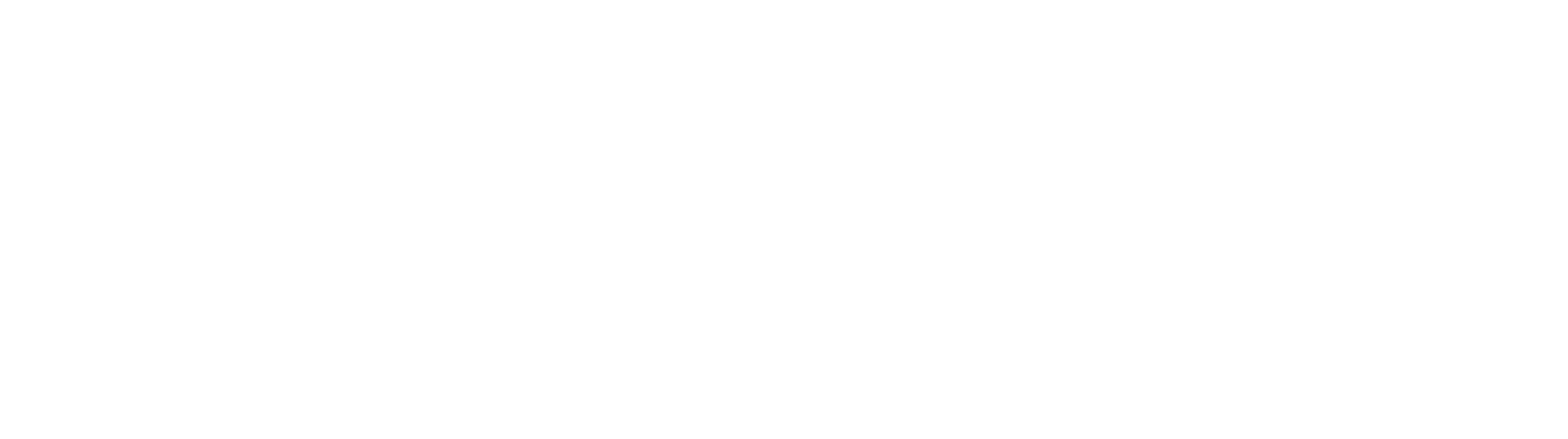Attività professionale svolta in forma di società
Introduzione
In questo articolo illustriamo le modalità di svolgimento in forma associata dell’attività professionale. In particolare, consideriamo dapprima la possibilità di esercitare la professione attraverso una società commerciale e attraverso una società tra professionisti (STP). Accenniamo poi alle società odontoiatriche e a quelle per la gestione delle farmacie, per soffermarci infine sulla qualificazione del reddito ai fini fiscali e sulle modalità di tassazione.
Iniziamo riportando la risposta del Ministero dello Sviluppo Economico ad un quesito di un Ufficio del registro delle imprese, che chiedeva se un’attività professionale protetta potesse essere esercitata in forma di società commerciale, diversa dalla società tra professionisti (STP) (MISE, Prot. n. 415099 del 23/12/2016).
- Introduzione
- Contesto normativo
- Cliniche, società di mezzi e di servizi imprenditoriali
- La Società Tra Professionisti (STP)
- Non è possibile esercitare le professioni protette tramite società commerciali
- Società odontoiatrica (non è una Società Tra Professionisti)
- Società per la gestione di farmacie (non è una Società Tra Professionisti)
- Le altre professioni sanitarie possono costituire Società Tra Professionisti (STP)
- Qualificazione fiscale del reddito prodotto dalla Società Tra Professionisti (STP)
- Qualificazione fiscale del reddito prodotto dagli studi associati
- La tassazione per trasparenza delle società di persone e degli studi associati
Contesto normativo
“È noto che la legge 1815/1939 ha, nel nostro ordinamento, per molti anni, vietato lo svolgimento delle cosiddette “professioni protette” nella forma delle società commerciali.
È noto, altresì, che ciò non precludeva lo svolgimento di attività professionali ordinistiche nell’ambito di società, purché nel rispetto di ben determinati principi, ben riassunti nella rinomata sentenza della Cassazione civile n. 7738 del 13/07/1993 (<<[ … ] Tale pronuncia della Corte costituzionale [ordinanza 21/01/1988, n. 71] chiaramente presuppone l’applicabilità all’attività sanitaria, come professione “protetta”, della disciplina dettata dalla legge n. 1815 del 1939 (MISE, cit.).
Cliniche, società di mezzi e di servizi imprenditoriali
Ma tale applicabilità non esclude che sia consentita, nell’ambito dell’attività sanitaria, la costituzione di società, purché tale costituzione avvenga per offrire un prodotto diverso e più complesso rispetto all’opera dei singoli professionisti, quale è la prestazione di servizi che trascendono l’oggetto delle professioni protette (come potrebbe essere, ad esempio, l’esercizio di una clinica rispetto alle prestazioni di un medico o quello delle c.d. società di “engineering” rispetto alla prestazione di un ingegnere: cfr. in tal senso Cass., sent n. 1405/1989 e 566/1985) ovvero nel caso in cui la società abbia ad oggetto soltanto la realizzazione e la gestione dei mezzi strumentali per l’esercizio d’una attività professionale ancorché protetta (comprensiva di immobili, arredamenti, macchinari, servizi ausiliari) che, peraltro, resti nettamente separata e distinta dall’organizzazione dei beni di cui si serve, anche sul piano contabile.
Ciò si verifica quando tra la società ed il professionista – che si pongano l’una rispetto all’altro come soggetti chiaramente diversi – intervenga un contratto per l’effetto del quale la società si obbliga a fornire al professionista tutti i beni strumentali e i servizi (accessori che consentono o facilitano, ma certamente non esauriscono, l’elemento specifico dell’attività professionale, che deve essere prestata personalmente, come stabilito dall’art. 2232 c.c. con le sole eccezioni ivi previste), e dall’altro lato, il professionista si impegna a pagare alla società un corrispettivo o in misura fissa ovvero in proporzione dei suoi proventi professionali.
La liceità di un siffatto contrato (v. Cass., sent. n. 5656 del 13 maggio 1992, con specifico riferimento ad una società per la gestione di un gabinetto di analisi chimico cliniche) trova il suo fondamento, da un lato, nell’autonomia contrattuale (riconosciuta dall’art. 1322 per tutti quei contratti che, pur non appartenendo ai tipi aventi una disciplina normativa particolare, siano però diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela) e, d’altro lato, nella constatazione che, rimanendo il professionista l’unico soggetto direttamente in contatto con la propria clientela, che da lui soltanto riceve la prestazione professionale (sia pure grazie ai mezzi fornitigli dalla società), non viene compromesso il carattere personalissimo che la prestazione deve avere, né il correlativo apprezzamento dell’ “intuitus personae”, né, in definitiva, il prestigio stesso che la professione “protetta” deve avere per meritare la fiducia del pubblico: cioè nessuno di quei valori a tutela dei quali la legge vieta l’esercizio delle c.d. “professioni protette” nelle forme della società commerciale>>) (MISE, cit.).
La Società Tra Professionisti (STP)
Tale divieto di svolgimento delle professioni protette nella forma di società commerciale ha subito una prima “incrinatura” ad opera dell’art. 24 della legge 266/1997 (cosiddetto “decreto Bersani 1”), con cui veniva abrogato l’art. 2 della citata legge n. 1815; ciò non ha determinato, tuttavia, una riforma organica della materia in quanto non furono mai emanate le relative norme attuative.
Ed anche il successivo DL 223/06, in materia di “società multidisciplinari” (cosiddetto “decreto Bersani 2”) non ha avuto miglior sorte, atteso che anche in questo caso non furono mai emanate le norme attuative.
Va rilevato, tuttavia che già nel 2001 (artt. 16 e ss. del DLGS 96/2001) era stata prevista espressamente la possibilità di svolgimento di una attività professionale protetta in forma societaria, ma solo per una determinata professione e secondo una ben specifica modalità (società tra avvocati).
Infine, la legge 183/2011 (art. 10, commi da 3 a 11) ha finalmente previsto la società tra professionisti in modo espresso, mantenendo nel contempo la possibilità di esercitare tali attività secondo i modelli associativi già esistenti (ad esempio, studio associato). Le norme attuative delle disposizioni in ultimo richiamate sono contenute nel decreto regolamentare 34/2013, emanato dal Ministero della giustizia di concerto con questa Amministrazione.
Le norme in questione consentono lo svolgimento delle professioni protette nella forma (art. 10, comma 3, della legge 183/2011) della società semplice, della società in nome collettivo, della società in accomandita semplice, della società a responsabilità limitata, della società per azioni, della società in accomandita per azioni, nonché della cooperativa.
Non si tratta, come evidenziano unanimemente i commentatori, di nuovi “tipi” societari: si applicano, infatti, a ciascuno, le regole proprie del modello societario adottato, salve le deroghe e le integrazioni previste dalla disciplina speciale.
Deroghe ed integrazioni volte a “contemperare” la maggiore efficienza offerta dallo strumento societario con la peculiare tutela del cliente che contraddistingue la prestazione professionale.
E’ stata, pertanto, a titolo di esempio, prevista (art. 10, comma 4, lett. “b”, della legge 183 cit.) la “prevalenza” dei soci-professionisti nella gestione societaria: <<In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci>>.
Oggetto esclusivo delle società in questione è, inoltre, l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (art. 10, comma 3, della legge 183).
La società tra professionisti è tenuta, altresì, a stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale (art. 10, comma 4, lett. “c-bis”).
Va rammentato, ancora, che la società tra professionisti è tenuta ad iscriversi all’albo professionale competente (art. 10, comma 4, lett. “b”) ed è soggetta al relativo regime disciplinare (art. 10, comma 7).
La partecipazione ad una società tra professionisti è, inoltre, incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti (art. 10, comma 6); la ragione o denominazione sociale deve contenere l’indicazione “società tra professionisti” (art. 10, comma 5); il socio per finalità d’investimento deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale cui la società è iscritta (art. 6, comma 3, lett. “a”, del decreto 34/2013) (MISE, cit.).
Non è possibile esercitare le professioni protette tramite società commerciali
Anche sulla semplice scorta degli elementi distintivi sopra sinteticamente esposti sembra doversi concordare con codesto Ufficio circa il fatto che la disciplina inerente le società tra professionisti costituisce, allo stato attuale, l’unico contesto nel cui ambito è possibile <<l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile>>.
Ciò, come già chiarito, ove lo svolgimento dell’attività professionale “protetta” (o di più attività professionali “protette”) costituisca l’oggetto esclusivo della società stessa: solo tale cornice normativa fornisce, infatti, puntuali parametri volti ad equilibrare e contemperare i contrastanti interessi (l’interesse all’efficienza e allo sviluppo della concorrenza, da una parte; l’interesse a tutelare l’affidamento del cliente nel momento in cui riceve servizi connotati da particolare delicatezza e “sensibilità” dall’altra) che nella fattispecie si confrontano.
Parametri che, ovviamente, verrebbero completamente a mancare ove si ammettesse la possibilità di svolgere le medesime attività “protette” nella forma di “generiche” società commerciali.
Strumenti, questi ultimi, che, tuttavia, come affermato da codesto medesimo Ufficio (e coerentemente con la citata sentenza della Cassazione civile n. 7738) ben potranno essere utilizzati al fine di costituire società “di mezzi”, oppure società in cui l’aspetto organizzativo e capitalistico risulti del tutto prevalente rispetto allo svolgimento (pur presente) di attività professionali “protette” […].” (MISE, cit.).
Società odontoiatrica (non è una Società Tra Professionisti)
Fino al 2017, anche la professione di medico odontoiatra, come esposto nel precedente paragrafo, poteva essere svolta solo nella forma della Società Tra Professionisti (STP).
Tuttavia, la legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017, ha consentito l’esercizio dell’attività odontoiatrica anche alle società operanti nel settore le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni odontoiatriche siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti previsti dalla legge. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti appena citati. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura (art. 1, co. 153-156, L. n. 124/2017).
Società per la gestione di farmacie (non è una Società Tra Professionisti)
“La gestione di farmacia costituisce una attività legata alla professione e collegata al servizio pubblico sanitario. […] Si tratta, però, di attività non solo professionale, ma anche “imprenditoriale” poiché prevede operazioni economiche – come le “vendite” – e, quindi, deve essere qualificata come “di impresa” sussistendo i requisiti indicati negli articoli 2082 e 2238 del codice civile. Può, dunque, affermarsi che la gestione della farmacia mediante una società è sintesi di attività intellettuale e di attività commerciale, unificate dal pubblico interesse, ed è un tipico caso di esercizio della professione intesa come elemento di un’attività organizzata in forma di impresa” (CNN, Studio n. 155-2009/I L’oggetto sociale della società di gestione di farmacia e riflessi notarili, 18 giugno 2009, pag. 2).
Le società per la gestione di farmacia sono disciplinate dalla L. n. 362/1991, come modificata dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017.
In particolare, sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata.
Le società di cui sopra hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia e la partecipazione a queste è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica.
La direzione della farmacia gestita da una società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dalla legge, che ne è responsabile (art. 7, L. n. 362/1991).
Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite in economia, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari, o a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità (art. 10, L. n. 362/1991). Inoltre, “l’art. 12, L. n. 498/1992 ha consentito la costituzione di apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà maggioritaria dell’ente locale. Conseguentemente, le farmacie “comunali” […] possono essere gestite da s.p.a. o d s.r.l. a partecipazione pubblica maggioritaria o minoritaria, con la necessaria partecipazione al capitale, quali soci privati, di farmacisti scelti attraverso l’espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica (c.d. società a capitale misto pubblico-privato)” (CNN, Studio n. 155-2009/I L’oggetto sociale della società di gestione di farmacia e riflessi notarili, 18 giugno 2009, pag. 9).
Le altre professioni sanitarie possono costituire Società Tra Professionisti (STP)
Con la L. n. 43/2006 “è stata data al Governo la delega per l’istituzione degli ordini professionali relativi alle cc.dd. professioni sanitarie ausiliarie”.
La delega riguarda le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione previste ai sensi della L. n. 251/200 e del D.M. 29 marzo 2001 del Ministro della Sanità.
Sulla possibilità di esercitare tali professioni nella forma di società tra professionisti, il Ministero dello Sviluppo Economico aveva indicato che “sino al momento della istituzione tramite decreto legislativo, delegato dal richiamato art. 4 della legge 43 del 2006, dell’ordine o collegio dei fisioterapisti [n.d.r. e delle altre professioni sanitarie] chiamato a tenere il relativo albo, non è consentita agli stessi la costituzione in via esclusiva di società tra professionisti. Appare invece possibile che gli stessi partecipino a società tra professionisti (oltre ovviamente che in posizione di soci per finalità di investimento) anche in posizione di “soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche” di cui alla lettera b) del comma 4, dell’art. 10 della legge 183/2011” (MISE, nota del 15 febbraio 2016, prot. 39343).
La tesi di cui sopra era già allora controversa, ma se le altre professioni sanitarie (un tempo definite ausiliarie) dovevano ancora considerarsi come “non protette”, per l’esercizio in comune di tali attività era possibile costituire qualunque società diversa da quella tra professionisti di cui alla L. n. 183/2011 o di cui alla L. n. 1815/1939 (cfr. A. Busani, M. Corso, Gli Oggetti delle Società, IPSOA, II ed., 2020, p. 514).
La posizione di cui sopra deve oggi considerarsi superata, poiché ad istituire gli ordini professionali è successivamente intervenuta la legge delega n. 3/2018 (c.d. legge Lorenzin). In particolare, l’art. 4 rubricato Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie sostituisce l’art. 1 del D.Lgs. n. 233/1946 e dispone che “Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. […]”.
Gli Ordini professionali e le relative federazioni nazionali sono stati costituiti per tutte le professioni indicate nella legge. Nello specifico, la professione di fisioterapista rientra nelle professioni sanitarie della riabilitazione e gli Ordini professionali dei fisioterapisti sono stati istituiti a livello territoriale con D.M. 183/2022 insieme alla Federazione nazionale, sulla base della L. 3/2018.
In conclusione, tutte le professioni sanitarie per le quali è stato istituito un ordine professionale devono considerarsi “professioni protette” e l’esercizio in comune di tali attività può essere esercitato tramite associazioni professionali o società tra professionisti (STP).
Qualificazione fiscale del reddito prodotto dalla Società Tra Professionisti (STP)
L’Agenzia delle Entrate, in una risposta ad interpello del 8 maggio 2014, ha specificato che “anche per le s.t.p. trovano conferma le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa.
Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle s.t.p., non assume alcuna rilevanza, pertanto, l’esercizio dell’attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria.”
Alla luce di quanto sopra, i redditi prodotti dalla s.t.p. costituita sia nella forma di società di capitali (s.r.l.), che nella forma di società di persone commerciali (s.n.c. o s.a.s.) sono redditi di impresa.
“In considerazione della natura del reddito prodotto, i compensi relativi alle prestazioni rese dalla s.t.p. non sono soggetti alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973”.
Qualificazione fiscale del reddito prodotto dagli studi associati
Il reddito prodotto dagli studi associati, ossia dalle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni (equiparate alle società semplici) è qualificato come reddito di lavoro autonomo.
Si segnala che l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata dalla quale si evinca la quota di partecipazione agli utili di ciascun associato possono essere redatti fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione (art. 5, D.P.R. n. 917/1986).
I compensi pagati allo studio associato sono soggetti alla ritenuta d’acconto sul reddito di lavoro autonomo.
Lo studio associato, che subisce in proprio le ritenute, e che deve poi provvedere al trasferimento delle stesse agli associati in proporzione alle quote di partecipazione, può avocare a sé le ritenute che residuano dopo il loro scomputo dall’IRPEF dovuta dai medesimi, per utilizzare in compensazione il credito ad esse relativo, purché i soci diano il loro assenso con atto avente data certa anteriore all’utilizzo in compensazione, o nell’atto costitutivo (Circolare n. 12/E/2010, par. 2.10).
La tassazione per trasparenza delle società di persone e degli studi associati
In generale, con riferimento alle s.t.p. costituite in forma di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) e agli studi associati, la tassazione del reddito avviene in base al principio della trasparenza, attribuendo a ciascun socio o associato la propria quota di reddito IRPEF. In tal modo, i redditi di partecipazione mantengono la stessa natura che hanno in capo alla società o associazione da cui provengono: i redditi delle s.n.c. e delle s.a.s. mantengono la qualificazione di redditi di impresa, mentre i redditi delle associazioni professionali e delle società semplici mantengono la qualificazione di reddito di lavoro autonomo e vengono indicati come tali nella dichiarazione dei redditi del socio o dell’associato.
Le società di persone e le associazioni professionali non versano l’IRPEF: presentano una dichiarazione dei redditi al fine di calcolare il reddito complessivo, che viene attribuito pro-quota ai soci o associati. Quest’ultimi indicano la propria quota di reddito nella loro dichiarazione dei redditi e versano l’IRPEF.
Le società di persone e le associazioni professionali, invece, versano direttamente IRAP, IVA e ritenute applicate come sostituto di imposta. Le relative dichiarazioni, inoltre, sono presentate unicamente dalla società o associazione professionale, ma non dai soci.
11 marzo 2023
[armelse]
[/arm_restrict_content]